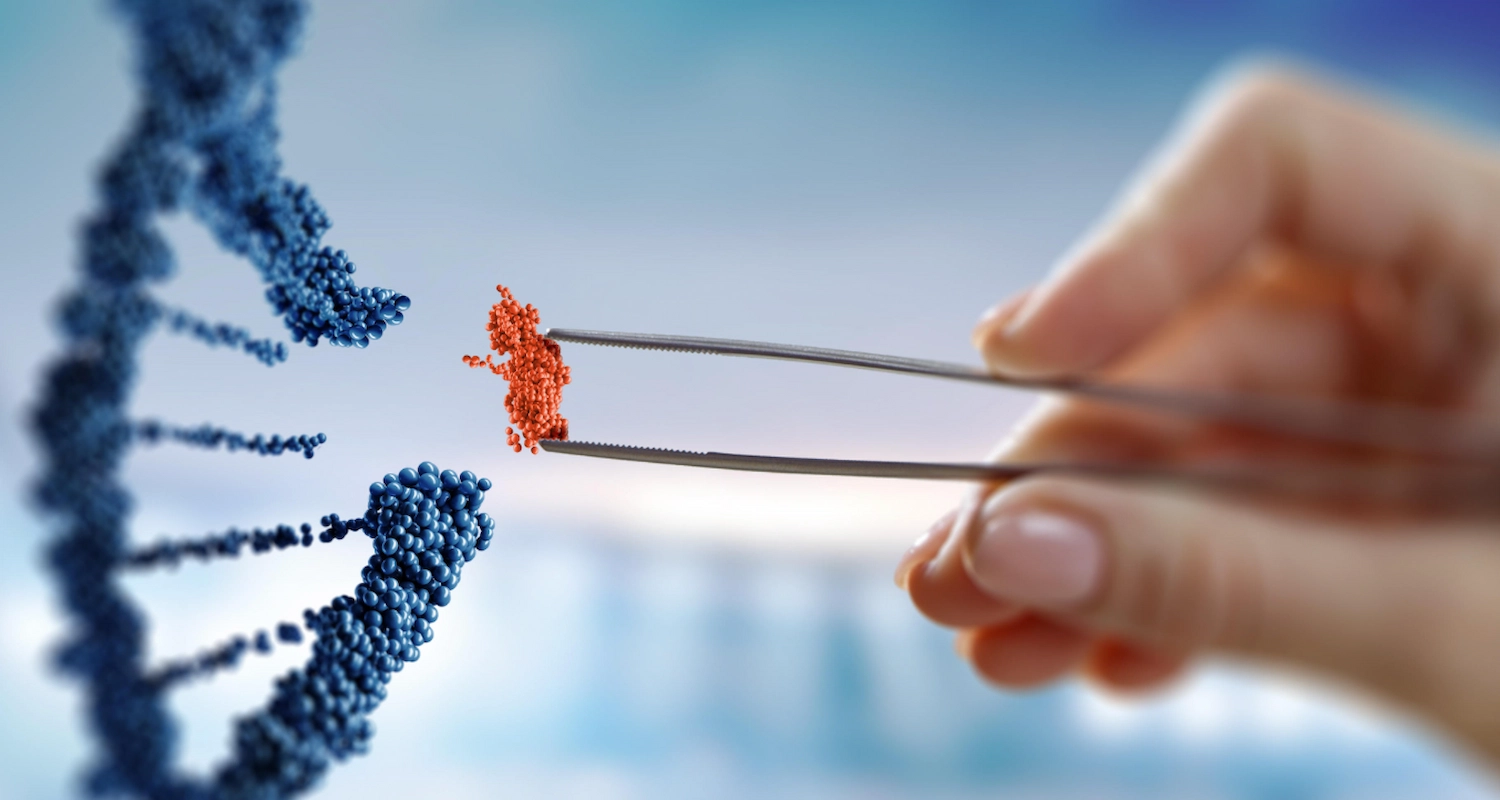Quando un illustre ma anziano scienziato sostiene che qualcosa è possibile, ha quasi certamente ragione, ma quando sostiene che qualcosa è impossibile, ha quasi certamente torto.
Arthur C. Clarke
«con lui pur movevano ancelle sculte nell’oro, che in tutto sembravano vive fanciulle, perché senno entro i petti racchiudono, e forza, e favella, e sperte sono, in grazia dei Numi, nell’opere belle; e ansavan sotto il peso del loro signore.»
Omero, Iliade, Libro 18
Di cosa sta parlando Omero? Chi sono quelle ancelle fatte d’oro, capaci di comprendere e parlare, nonché dotate di una forza e una abilità nel lavoro manuale tali da consentire loro di aiutare il fabbro Efesto a compiere il proprio lavoro? O che cosa sono?
Per me, e non solo per me, sono inequivocabilmente robot. E a meno che non si creda che gli alieni siano all’origine della civiltà umana, e che quindi i robot siano qualcosa di cui Omero è stato effettivamente testimone, dobbiamo ammettere che lui (o loro) è stato in grado di immaginare esseri meccanizzati 2.700 anni prima di noi.
Spostiamoci ora verso est, in India, e leggiamo alcuni versi del Ramayana, uno dei testi sacri degli indù (IV secolo a.C.), contenuti nel quinto libro: «Lì il grande Hanuma vide una grande macchina aerea, la migliore tra le migliori macchine aeree, che dal nome di Pushpaka risplendeva attraverso i raggi delle sue pietre preziose, e capace di percorrere lunghe distanze».
Questi sono i Vimana, carri volanti in grado di percorrere grandi distanze e di trasportare svariate persone. Dunque, possiamo considerare questi – o la Mitologia nella sua interezza – i primi testi di fantascienza?
Non ho le competenze per spingermi in affermazioni più avventurose, e credo che prevedere il futuro non fosse tra le tante funzioni dei miti, ma sicuramente, se non apparteniamo a una delle tante sette dell’Area 51, questa capacità di immaginare cose ben al di là di ciò che era noto e possibile è davvero sorprendente.
Ciò che ha sempre stimolato la mia curiosità fin dalla prima lettura di “Dalla Terra alla Luna” di Jules Verne e del suo seguito, “Intorno alla Luna”, è stata la capacità di immaginare anzitempo non solo oggetti, strumenti e macchine, ma anche eventi e conquiste che gli scrittori di fantascienza, e successivamente i registi cinematografici, hanno sempre dimostrato di avere. Nei libri citati non si immagina solo un “proiettile” che vola verso il nostro satellite, ma l’impresa, il contesto (comprese le tute spaziali) e le domande che ne derivano, il tutto più di 100 anni prima del loro effettivo accadimento.
È incredibile quante innovazioni reali siano state previste decenni prima della realizzazione degli oggetti stessi. Anche Verne parla di un sommergibile (nucleare?) nel suo “20.000 leghe sotto i mari”, dei taser (fucili elettrici) e dei veicoli a propulsione elettrica.
Anche Salgari, lo scrittore italiano di avventure noto soprattutto per i suoi romanzi di pirati, scrive nel suo libro “Le meraviglie del duemila” di qualcosa di molto simile ai televisori a schermo piatto, ai viaggi aerei, alle videocomunicazioni, ai treni ad alta velocità, ai bancomat e ai sistemi di controllo ambientale.
E l’elenco di ciò che gli scrittori di fantascienza sono stati in grado di prevedere può continuare all’infinito: realtà virtuale, William Gibson; viaggi spaziali, H.G. Wells (dopo Verne); intelligenza artificiale, A.C. Clarke e I. Asimov; le interfacce gestuali, Spielberg e P.K. Dick; satelliti, A.C. Clarke; Voice2text, Asimov. Ovviamente anche loro si sono sbagliati, almeno per il momento. Basti pensare alle auto volanti, al teletrasporto, ai viaggi nel tempo, agli androidi, alla creazione della vita.
Che dire invece della capacità della scienza di fare previsioni? L’onnipotente scienza e la sua sorellastra, la tecnologia, hanno un trascorso più dubbio. È vero che hanno previsto auto a guida autonoma, touchscreen, GPS, ma il numero di errori, soprattutto pensando a un futuro lontano, è più alto.
Dalle grandi imprese come gli oggetti volanti più pesanti dell’aria, fatto ritenuto impossibile da Lord Kelvin, alle comunicazioni radio intercontinentali, ai voli supersonici, alle missioni con equipaggio nello spazio, al millennium bug, fino alle piccole cose di tutti i giorni, come l’ufficio senza carta, i veicoli a propulsione nucleare, i televisori 3D.
Com’è possibile? E com’è possibile che molte delle cose realizzate dalla scienza e dalla tecnologia fossero già state pensate nelle opere di fantascienza?
A questo punto dovreste aver capito dove sto andando a parare e potreste obiettare che il paragone è fuori luogo: perché accostare degli esercizi di fantasia ai risultati della vera scienza e della tecnologia?
Dopotutto, ciò che la tecnologia produce è per definizione dubbio possibile, mentre la fantascienza rappresenta tutt’al più un’ipotesi azzardata.
Tuttavia, è sorprendente scoprire quanti scienziati e tecnologi leggono regolarmente di fantascienza traendone ispirazione. E non è un caso che molti scrittori di fantascienza fossero e siano essi stessi scienziati o ingegneri: Asimov, Heinlein, Clarke, Sagan, solo per citarne alcuni.
Come illuminanti sono le discussioni sui siti web del MIT Technology Review e dell’Engineering Institute of Technology sull’interazione tra questo genere letterario e le STEM.
Si tratta in effetti di un evidente ciclo di retroazione (circolo virtuoso), e non di una relazione lineare, in cui a volte le speculazioni scientifiche influenzano il lavoro degli autori e viceversa.
E questo è il primo modo in cui la fantascienza contribuisce allo sviluppo tecnologico, agendo come una sorta di sfida che assai di frequente viene raccolta da scienziati e tecnologi. Infatti, come afferma Einstein:
«l’immaginazione è più importante della conoscenza.»
Troppo spesso la scienza e la tecnologia sono state (e continuano a essere) intrappolate nei paradigmi che le hanno generate, rendendole prigioniere degli stessi, mentre la fantasia è per definizione libera dai limiti di ciò che è noto.
Questo è ciò che ha portato Arthur C. Clarke a dire che «quando un illustre ma anziano scienziato sostiene che qualcosa è possibile, ha quasi certamente ragione, ma quando sostiene che qualcosa è impossibile, ha quasi certamente torto». Oggi come in passato, la tecnologia è ancora vincolata a ciò che è considerato possibile, ma allo stesso tempo trae energia dalla fertilizzazione incrociata tra domini diversi, ricevendo un’accelerazione che comprime la distanza dal futuro, «impedendoci di immaginare le sue possibilità molto più numerose, complesse e, in definitiva, stimolanti; i futuri possibili, per essere ‘sognati’, richiedono uno scarto minimo da questo stesso momento», come dice più efficacemente l’amico Giorgio Di Tullio.
Diventa un valore in sé e per sé al punto che molti, ancor più quelli che operano in ambiti in cui la sua velocità è massima, la ritengono sinonimo di innovazione e si sorprendono quando viene rifiutata dal “mercato” o quando va ben oltre le aspettative iniziali.
Non è un caso che, nel corso degli anni, molti leader del settore non siano riusciti a comprendere gli sviluppi del medesimo settore a cui appartengono. Da Ken Olsen, il geniale fondatore di Digital, che sosteneva che non c’era motivo di volere un computer in casa, a Steve Balmer, il quale aveva già dato per certo il completo fallimento del lancio dell’iPhone. Il problema più grande è la sua natura molto pratica e materiale, poiché esiste negli strumenti che produce e ha una copertura per lo più circoscritta alle sue applicazioni.
Ma un progresso tecnologico e scientifico diventa un’innovazione solo se crea valore, e il valore può essere giudicato solo dal suo impatto sulla società umana o su parti di essa. Il punto è che viviamo in un mondo complesso in cui l’emergenza e i suoi picchi, i cigni neri, sono la regola. Pertanto, la questione va ben oltre gli apparecchi e le loro applicazioni funzionali, che possono essere in una certa misura prevedibili (a meno che non si tratti di utilizzi alternativi e fortuiti), per arrivare all’influenza che possono avere sulla società nel suo complesso, dove non è possibile fare previsioni (senza offesa per gli economisti, la cui incapacità di previsione, ancorché arricchita da un discreto grado di approssimazione, farebbe licenziare chiunque in altri settori).
Dobbiamo riacquistare la capacità di osservare il quadro generale, ed ecco il secondo modo in cui la fantascienza può essere d’aiuto. Ma la mia idea di come funziona la buona fantascienza è quella di fare delle premesse tecnologiche spesso estreme, che una volta accettate ci conducono in un mondo molto coerente fondato su di esse.
Ciò significa che i possibili esiti si dipanano all’interno di un groviglio di relazioni esteso a tutti i livelli: da uomo a uomo, da uomo a macchina (come dimenticare lo scambio tra Hal e Dave in “2001: Odissea nello spazio”) e da macchina a macchina.
Si tratta ovviamente di “semplici” speculazioni, ma il vero e proprio fallimento delle previsioni tradizionali (si pensi alla Brexit, a Trump, alla guerra in Ucraina, all’impatto della pandemia di Covid…) impone un approccio al futuro completamente diverso. È ciò che chiamiamo “fore-sighting”, in cui la sfida non è rappresentata da previsioni numeriche accurate (e impossibili), bensì da scenari qualitativi ed esplorativi, workshop e pareri di esperti volti a esaminare le possibili tendenze e perturbazioni imminenti, al fine di preparare e modellare gli sviluppi futuri.
Ci troviamo di fronte a una svolta in termini di pianificazione strategica ed elaborazione delle policy, alle quali è demandato non tanto il compito di indicare il modo in cui le aziende e le organizzazioni devono muoversi per avere successo in mercati chiaramente definiti, quanto piuttosto la selezione delle azioni che possano aiutarle a prosperare o almeno a sopravvivere nella maggior parte degli scenari.
Io inizio molti incarichi di sviluppo di innovazione con la proiezione di un episodio di “Black Mirror”. Le trame delle serie tv distopiche sono un esempio perfetto di come immaginare il futuro sfuggendo alla tradizionale e inefficace pianificazione aziendale.
Infatti, per immaginare il futuro che vogliamo e farlo “accadere”, dobbiamo imparare a pensare come un autore di fantascienza.