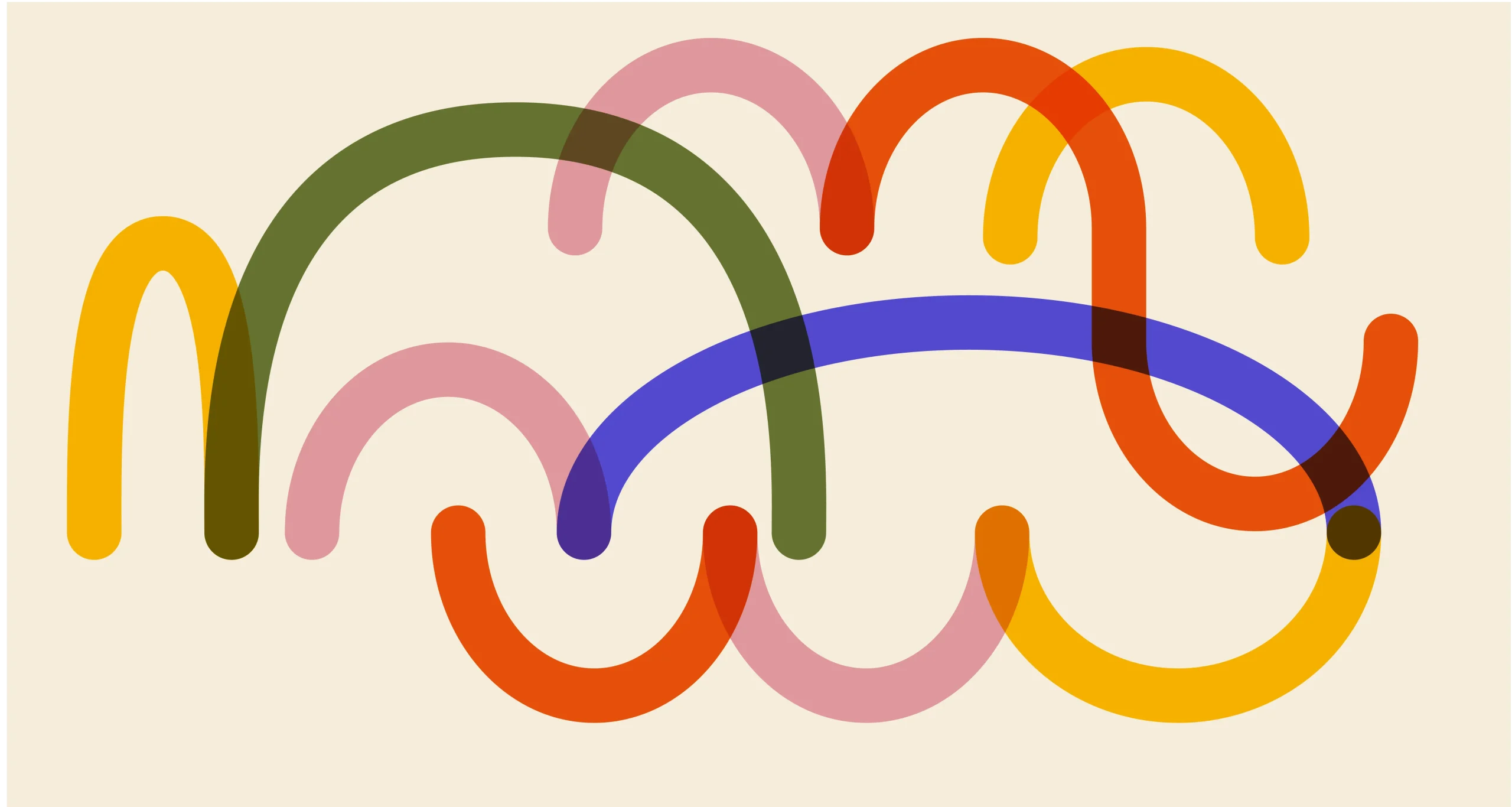Il volo United Airlines 173, diretto da New York a Portland, non è mai arrivato a destinazione. Era il dicembre del 1978.
Il carrello di atterraggio sembrava danneggiato, il comandante decise di mantenere l’aereo in volo, in attesa di indicazioni dalla torre di controllo. Per quasi un’ora rimasero a girare sopra la città, cercando di risolvere il problema mentre il carburante si consumava.
E mentre il carburante scendeva sotto i livelli di guardia, nessuno parlava davvero, nel senso di comunicare. Il comandante era concentrato sul carrello, i copiloti sapevano che stava per finire il carburante ma non lo dissero veramente, uno di loro lo accennò, l’altro lo chiese a mezza voce, il comandante minimizzò e loro smisero di insistere. Pochi minuti dopo le 18, l’aereo precipitò a poche miglia dalla pista e morirono dieci persone.
Durante l’inchiesta si scoprì che il problema non era tecnico, era umano. Nessuno aveva avuto il coraggio, o la possibilità, di dire: “Dobbiamo atterrare subito”. Nessuno si era sentito autorizzato a contraddire il comandante. Perché nella cabina di pilotaggio regnava un silenzio gerarchico, un silenzio che costò davvero caro, la vita di 10 persone.
Se oggi nei cockpit degli aerei commerciali si parla di Crew Resource Management, è grazie a incidenti come quello. È grazie a quella tragica lezione: non basta essere esperti. Bisogna potersi parlare.
Serve uno spazio in cui la verità possa emergere, anche se scomoda, anche se detta da chi ha meno voce.
Amy Edmondson, professoressa alla Harvard Business School, ha studiato per trent’anni i contesti dove questo spazio esiste. Lo chiama psychological safety, sicurezza psicologica. Ma attenzione: non immaginare un luogo morbido o un clima di serenità e pace. È una condizione dinamica, instabile, viva. È la sensazione profonda che si può sbagliare senza essere puniti, che si può dissentire senza essere messi da parte, che si può dire la verità, anche quando fa attrito con la verità di qualcun altro.
Uno degli elementi più sottovalutati infatti è il sense of purpose. Sentire che il proprio lavoro contribuisce a qualcosa di più grande, che non è solo un ingranaggio in un meccanismo produttivo, ma parte di una visione più ampia, fa la differenza. Nelle aziende dove questo senso è chiaro, dove il contributo di ognuno viene riconosciuto e dove le persone sentono di essere parte di qualcosa che le trascende, la gioia non è un’eccezione, ma un’esperienza quotidiana.
E qui entra in gioco un altro elemento fondamentale: il desiderio. Daniel Z. Lieberman, nel suo libro Dopamina. La chimica dei desideri, descrive come la dopamina sia la forza trainante dell’ambizione umana. Non si attiva con il raggiungimento di un obiettivo, ma con l’anticipazione di un nuovo traguardo. È la stessa spinta che ci porta a cercare, a immaginare il futuro e a costruire ciò che ancora non esiste. Se la dopamina accende il desiderio, la gioia è il carburante che permette di sostenerlo nel tempo. E il mondo del lavoro non fa eccezione.
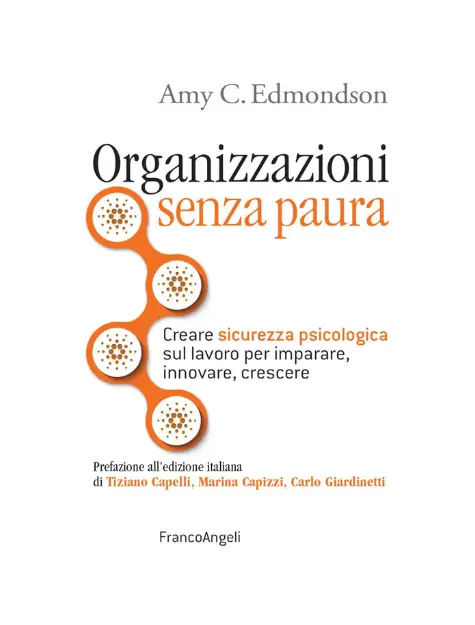
Nel suo libro Organizzazioni senza paura, Edmondson lo dice chiaramente:
la Psychological Safety è più qualcosa a cui aspirare continuamente, che un obiettivo da raggiungere una volta per tutte.
Descrive questo come un viaggio dinamico e infinito, una tendenza, un’ambizione che i team devono alimentare di continuo mediante l’analisi di dinamiche interne e schemi disfunzionali o non aperti. Non è un traguardo, è una pratica, non è un risultato, è una tensione. Una spinta continua verso una cultura dell’ascolto, della parola che prende forma dentro una responsabilità condivisa.
Ed è pure un paradosso: per creare sicurezza, bisogna essere disposti a correre piccoli rischi relazionali. Bisogna esporsi. Dire: “non ho capito”, “Non sono d’accordo”, “Mi sembra pericoloso”.
Non dobbiamo immaginarci casi eclatanti come quello del volo United Airlines 173, la sicurezza psicologica può “salvare” in ogni momento. Altra sua stranezza, la sicurezza psicologica è invisibile quando c’è, ma la sua assenza pesa e si vede in maniera lampante. È nella pausa in cui nessuno risponde, nello sguardo evitato, nella proposta che si spegne a metà frase, nel collega che ha un’idea ma se la tiene per sé, nella manager che nota qualcosa ma non lo dice. È in quel momento in cui si sceglie di non disturbare l’ordine, anche se l’ordine è sbagliato. Eppure, basterebbe poco: un gesto, una risposta, un invito autentico.

Parlando con Pietro, uno dei nostri Wyders, ci ha ricordato proprio questo: che il modo più potente per alimentare la sicurezza psicologica è agire come se ci fosse già. Come se il team fosse già uno spazio di libertà. Come se la fiducia fosse già lì, perché spesso è così che si innesca: per imitazione, per risonanza. Qualcuno prende la parola, e quel gesto diventa un permesso implicito per gli altri. Ma non si tratta solo di autorizzare le persone a parlare, serve qualcosa di più profondo: una cultura dell’ascolto. Ascolto che è presenza, disponibilità a cambiare idea, capacità di sostenere la voce dell’altro, anche quando ci mette in discussione. E in un team, il vero ostacolo all’espressione non è la mancanza di idee, ma la paura del giudizio. Quando quella paura si attenua (non sparisce, ma si allenta) allora può emergere qualcosa di raro: il pensiero vivo. Quello che si sta formando mentre lo si dice. Quello che ha bisogno dell’altro per prendere forma.
Tommaso, nostro Wyder, ci dice a questo proposito:
“La sicurezza psicologica è il frutto di una cultura organizzativa ben determinata che si esprime a livello dei gruppi di lavoro e che non può essere circoscritta a specifiche caratteristiche dei singoli che ne fanno parte. In quanto tale, può essere promossa e sostenuta attraverso interventi formativi e, soprattutto, mediante un continuo esercizio nella prassi quotidiana.”
Non esiste un’organizzazione che “ha” sicurezza psicologica una volta per tutte, esistono team che la coltivano ogni giorno, che si accorgono quando sta calando. E qui non c’è gerarchia che tenga: il clima lo costruisce chi ha potere decisionale, ma anche chi ha il coraggio di dire la frase scomoda. Lo costruisce chi si prende cura del modo in cui si lavora insieme. Chi non aspetta di sentirsi “sicuro” per parlare, ma parla per rendere il posto più sicuro anche per gli altri.
La cifra di un’azienda, da questo punto di vista, non si misura sulla base di quanti errori si fanno, ma da come si reagisce quando succedono.

Come Wyde, crediamo fermamente nel valore organizzativo della sicurezza psicologica e nei suoi impatti positivi sulla produttività e sull’ambiente di lavoro.
Proprio per questo siamo impegnati nel promuoverla e nel diffonderla attraverso il progetto Erasmus+ wellbeINTeam (Healthy and productive hybrid workplace environment in small and medium-sized enterprises).
- Siamo partner di progetto insieme a:
- Oic Poland Foundation Of Wsei University – Polonia – Project Leader
- Smartup N.B.Systematicmanagements.L.– Spagna
- Macrix Technology Group
Ti lasciamo con una domanda che potresti portare in azienda quando hai l’impressione che non ci sia franchezza nel team: non domandarti “perché non lo dice?” ma “che cosa possiamo fare, insieme, per renderlo dicibile?”
Ti suggeriamo alcuni gesti piccoli e semplici che possono fare la differenza fin da subito:
- dimezza le affermazioni e raddoppia le domande: non c’è sicurezza senza ascolto;
- concorda obiettivi di apprendimento accanto a quelli di business: crescere non è solo produrre di più;
- accetta le cattive notizie con curiosità ed equilibrio: anche questo è un modo per far sentire accolti.